Fuga sul Kenya
L’avventura di Felice Benuzzi raccontata da Carlo Alberto Pinelli.
Copyright: fascicolo di National Geographic/CAI, Montagne dell’Africa.

“L’aria era ferma, non spirava un alito. Feci qualche passo indietro per controllare se l’asta fosse a piombo. Lo era. E mentre guardavo un brivido mi corse per la schiena come se avvenisse qualcosa di soprannaturale: si levò da sud una brezza e il drappo, che già pendeva inerte, fremette, prese vita. Ecco, un lembo si solleva…la brezza diventa vento…il sangue mi martella nelle tempie…ecco, il rosso si spiega…il bianco…il verde; un attimo e il bianco rosso e verde si distende, si gonfia, sbatte, garrisce, libero! Libero!! E sventola in direzione nord, verso il campo dove fummo prigionieri, verso l’Italia. Non sapevo non potevo più trattenermi e piansi, piansi come un bambino”.
Questo commovente brano con cui culmina, ma non termina, il libro Fuga sul Kenya, fu scritto a caldo da Felice Benuzzi sul finire del 1943, per ricordare la sua salita alla Punta Lenana, terza vetta per altezza del Monte Kenya, in Africa.
Felice Benuzzi era un giovane italiano, originario di Trieste, campione di nuoto e grande appassionato di montagna. Nel 1941 lavorava ad Addis Abeba come funzionario del Ministero dell’Africa Orientale Italiana. Quando il nostro esercito venne annientato dagli inglesi in Somalia e in Etiopia, anche lui, come migliaia di altri prigionieri, militari e civili, fu avviato verso i campi di concentramento. Dopo un viaggio in treno che sembrava non avere mai fine, Benuzzi approdò nel campo di Nanyuki, ai piedi del monte Kenya. Vi restò richiuso per cinque anni. Con l’eccezione di 17 indimenticabili giorni.
Fu soltanto al termine della stagione delle piogge che Benuzzi riuscì a vedere per la prima volta, al dilà dei reticolati, il monte Kenya libero dalle nubi. Nel suo libro troviamo scritto: “Restai abbagliato. Così bello non me lo aspettavo. Come un assetato in mezzo al deserto cui sia apparso un miraggio di acque allettanti, rimasi lì, senza parola, a bocca aperta.”

Il monte Kenya è davvero una montagna affascinante. Un castello di roccia che sfiora i 5200 metri e innalza le sue cuspidi alla sommità di uno sterminato cono di tufi, conglomerati e antichissime colate laviche, coperto in basso da un anello di soffocanti foreste di bambù, allora regno di molti e pericolosi animali selvatici.
Posto quasi esattamente sulla linea dell’equatore, il Monte Kenya è considerato la montagna alpinisticamente più difficile dell’intera Africa. Le sue pareti verticali, i suoi scivoli ghiacciati, le sue creste, ancora oggi continuano a calamitare i sogni di generazioni di scalatori simili a Benuzzi.
Lui, oltre ad essere un alpinista era anche un bravo pittore dilettante. Con l’aiuto di un binocolo riuscì a disegnare tutti i dettagli dell’edificio sommitale che potevano suggerire un’ ipotetica via di salita. Poi, mentre l’esistenza tra le baracche continuava a trascinarsi senza scopo, cominciò a fantasticare sulla possibilità di evadere per tentare l’ascensione di quella vetta misteriosa e magnifica. Il sogno si trasformò presto in una ossessione. Per realizzarlo davvero occorrevano però due cose: un paio di compagni d’avventura, disposti a condividere il progetto; e gli attrezzi alpinistici adatti. Erano ostacoli non facili da superare. Dopo molti inutili tentativi, compiuti in gran segreto, finalmente altri due prigionieri accettarono di tentare l’impresa con lui. Solo uno era un buon alpinista. L’altro non aveva mai visto da vicino una montagna. Nessuno di loro aveva la minima cognizione da quale lato fosse già stato vinto il Monte Kenya. Ai tre fu necessario quasi un anno per riuscire a fabbricare, senza dare nell’occhio, i materiali e l’equipaggiamento necessari. Rottami di ferro recuperati in una discarica vennero trasformati in rozzi ramponi da ghiaccio e in approssimative piccozze. Per confezionare gli abiti si utilizzarono alcune coperte militari. Un’ improbabile corda venne ottenuta smontando le reti che sostenevano i materassi delle brande. I viveri necessari furono accantonati risparmiando sulle magre razioni quotidiane.

Nanyuki, il villaggio presso il quale sorgeva il campo si è trasformato ormai in un paesotto privo di qualunque attrattiva, simile a tutti gli agglomerati urbani che si possono incontrare lungo le principali strade di transito del Kenya. Dove sorgesse il campo di concentramento è difficile stabilirlo. I locali sembrano non ricordarne l’esistenza. Probabilmente occupava quella che è oggi una pianura agricola anonima, ai margini dell’abitato. Nessuna traccia resta dei baraccamenti, delle torrette di guardia, dei reticolati all’interno dei quali vennero stipati migliaia di italiani. Le condizioni di vita materiali non erano particolarmente dure: c’era da magiare, da dormire con adeguate coperte, e così via. Per sfamare i prigionieri venne abbattuta a poco a poco quasi la totalità delle zebre del Kenya settentrionale. Quella degli internati era soprattutto una sofferenza psicologica, dovuta alla mancanza di libertà, all’affollamento eccessivo, all’ozio forzato. Era angosciante vedere la vita che fuggiva senza scopo, mese dopo mese, anno dopo anno. Il progetto “folle” di Benuzzi e dei suoi due compagni nacque proprio come una reazione a quella claustrofobica frustrazione. Rappresentò una reazione disperata e romantica contro l’annullamento della personalità e l’umiliazione dello spirito causate dalla prigionia.

Subito fuori dai confini del campo le autorità inglesi permettevano ai prigionieri di coltivare – sotto stretta sorveglianza – piccoli orti. Su ogni appezzamento sorgeva una modesta capanna di frasche, nella quale venivano riposti, a sera, gli attrezzi agricoli. Proprio dentro una di quelle capanne si nascosero Benuzzi e i suoi due compagni quando giunse il giorno fatidico. Da una buca scavata sotto al pavimento vennero estratti i viveri e i materiali che vi erano stati depositati un poco alla volta, con la pazienza delle formiche. Le sentinelle Kikuyu non si accorsero del loro mancato rientro. Così, a notte fonda, tre ombre silenziose, cariche di pesantissimi zaini, si lasciarono alle spalle i reticolati e presero il cammino della montagna. Era il 24 gennaio del 1943.
Ai fuggiaschi occorsero otto giorni di inenarrabili fatiche per superare – alla cieca – la fascia della foresta. Adesso di fronte a loro si apriva uno sconfinato pendio erboso, solcato da avvallamenti e gobbe, punteggiato da seneci giganti e da lobelie argentate. Benuzzi annotò nel suo taccuino che sembrava di muoversi sulla superficie di un pianeta sconosciuto. Ovviamente nessuno di loro possedeva una macchina fotografica. Così Benuzzi decise di documentare le fasi salienti dell’avventura disegnando numerosi schizzi che in seguito trasformò in acquarelli. Sono pennellate leggere e già soffuse di nostalgia che ci restituiscono le atmosfere rarefatte di quel sogno di libertà.
Ora bisognava affrontare la scalata vera e propria. A causa dell’insufficiente adattamento all’ alta quota di uno dei tre, il campo base era stato posto molto lontano dalle prime pareti di roccia. Non solo: ormai i viveri erano quasi terminati. Pur sapendo che avrebbero dovuto affrontare la scalata in condizioni particolarmente sfavorevoli, Felice Benuzzi e Giuan Balletto decisero di sferrare lo stesso l’attacco. Era il 4 febbraio. Le prime luci del mattino trovarono i due italiani già molto in alto. Portavano con sé piccozze e ramponi fatti in casa ( che non utilizzarono mai!), un’ infida corda di fibra vegetale lunga meno di trenta metri e alcuni anelli di cordino. Purtroppo non avevano previsto chiodi da roccia.
Proprio per la mancanza di un’ attrezzatura minimamente adeguata il sogno dei due prigionieri italiani si infranse contro l’ultimo salto roccioso con cui termina un torrione della cresta nord-ovest chiamato “il piccolo gendarme”. Dopo vari tentativi il suo superamento si dimostrò superiore alle loro possibilità e li costrinse a una penosa e lunga ritirata.

Respinti dal piccolo gendarme, Felice Benuzzi e Giuan Balletto non si arresero. Decisero di risalire ancora una volta in alto per tentare di raggiungere almeno la vetta della più facile punta Lenana , la terza elevazione per altezza del massiccio del monte Kenya. I due erano digiuni da un paio di giorni, avevano i muscoli a pezzi e provenivano da un campo lontanissimo. Però a denti stretti riuscirono a compiere l’impresa e ad alzare sulla vetta la bandiera italiana, che avevano portato fin lassù, nascosta sotto la camicia. Tutti e tre avevano aderito al governo di Badoglio, quando gli inglesi li avevano posti di fronte a quella scelta; e certamente non erano al corrente della tragedia che stava soffrendo il loro paese a causa dei nazi-fascisti. L’Italia per entrambi era il miraggio della casa e della famiglia: la terra delle radici. In una parola la patria, nel senso più limpido ed elementare. Solo qualche imbecille potrebbe arricciare il naso supponendo che al centro di quella bandiera campeggiasse – come in effetti campeggiava – lo scudo sabaudo.
La bandiera fu vista, raggiunta e portata a Nairobi solo qualche giorno più tardi da una spedizione inglese proveniente dal lato opposto della montagna. Così la notizia, diffusa dall’agenzi Reuters, fece il giro del mondo e giunse anche in Italia dove offerse lo spunto per una retorica prima pagina della “Illustrazione del Popolo”. Quando la moglie, a Trieste, la vide, confessò agli amici: “ Sono sicura che è stato quel matto di Felice”.

Nel frattempo i tre italiani, esausti e affamati, riuscirono a rientrare di nascosto, qualche giorno più tardi, nel campo di prigionia. Il mattino successivo si presentarono all’appello come se niente fosse, lavati e sbarbati. Subito le autorità del campo li chiusero in un rigido isolamento. Però, appena la notizia dell’impresa divenne di dominio pubblico, gli stessi inglesi – con spirito sportivo – ne riconobbero il valore e resero in seguito meno pesante la prigionia dei tre protagonisti. Benuzzi scrisse la prima versione del libro, direttamente in inglese, quando viveva ancora nel campo. Le diede come ironico titolo “ No Picnic on Mount Kenya”.
Sono passati quasi ottant’anni da allora e sulla Lenana niente ricorda quell’ impresa. Però la bandiera dell’Italia, anche se ormai invisibile, continua a palpitare tra le rocce della vetta. Rimarrà lassù finché ci sarà qualcuno che saprà commuoversi, rivivendo la straordinaria avventura di Giuan, di Felice, di Enzo. Tre italiani di cui a ragione possiamo sentirci fieri.
Ho avuto l’onore di conoscere l’ambasciatore Felice Benuzzi durante le due gloriose giornate del convegno di Biella che, nel 1987, sancirono la nascita dell’associazione Mountain Wilderness. Associazione di cui entrambi fummo eletti tra i garanti. Purtroppo Felice Benuzzi morì l’anno successivo. Stefania, sua intrepida moglie, divenne in seguito per molti anni non solo la preziosa segretaria ma il vero pilastro del quartier generale di Mountain Wilderness. Fino al momento della sua scomparsa era considerata a ragione da tutti noi come la “madre” dell’associazione. E’ stata per me un’amica eccezionale. Dedico a lei, con infinito rimpianto, questo breve testo.
Carlo Alberto Pinelli
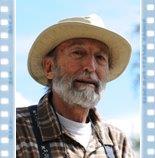
Alcune riflessioni in forma di post scriptum.
Ci sono stati e ci sono molti che hanno voluto vedere nell’impresa di Benuzzi e compagni una metafora dell’alpinismo. Alpinismo come fuga verso la libertà, dopo aver spezzato le catene inautentiche dell’ esistenza quotidiana. Non credo di poter essere d’accordo. E’ proprio la parola fuga a lasciarmi perplesso. Lasciamo da parte la ben nota sentenza in cui si afferma che diversa è la fuga del guerriero dal campo di battaglia dalla fuga del prigioniero dalla propria cella. Sono convinto che definire l’alpinismo come una fuga, anche se questa fuga insegue ingenuamente il richiamo della libertà, sia riduttivo e depistante. Se proprio dovessi circoscrivere l’alpinismo in una definizione, preferirei usare il termine pellegrinaggio. Si, proprio pellegrinaggio. Depurando però la parola da ogni connotato strettamente religioso ( ma non dalla sua tensione verso un incontro col mistero che si nasconde sul fondo di ciascuno di noi). Di per se stessa la fuga raramente supera e ricompone a un livello più alto l’antagonismo tra i due termini “prigione” e “libertà”. Cioè non aiuta a crescere. Invece il pellegrinaggio non rinnega la realtà quotidiana e non la sente come una prigione claustrofobica, pur prendendone le distanze per un certo lasso di tempo. Trascorso il quale è possibile ritornare entro l’orbita delle proprie professioni e dei propri doveri di figli, di padri, di sposi, arricchiti di una nuova consapevolezza interiore. In altre parole il pellegrinaggio ( nel caso in questione, verso i monti )ci permette una più articolata visione prospettica del nostro abituale rapporto con la quotidianità, liberandola dalla polvere delle abitudini che a poco a poco ne avevano offuscato il senso. Potrebbe addirittura essere malsano avvicinare i condizionamenti, le gioie, gli affanni, la complessità del mondo in cui viviamo ai fili spinati del campo di prigionia di Benuzzi.
