Una riflessione sulla speleologia e il rispetto per l’ambiente
“Rispettare l’ambiente naturale equivale a rispettare se stessi e i propri sogni”. Di Carlo Alberto Pinelli
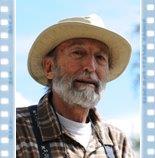
Nel documentario di Werner Herzog “ White Diamond”, ambientato nella foresta equatoriale della Guyana inglese, c’è una sequenza che mi ha particolarmente colpito. Alle spalle di una spettacolare cascata si apre un’ enorme caverna dove nessuno fino a quel momento era riuscito a entrare, a parte i rondoni. La caverna infatti si trova a metà di un’ ostile parete di roccia resa insuperabile dalla stessa selvaggia violenza dell’acqua. La squadra del regista decide però di raggiungere il bordo superiore della cascata per calare un alpinista fornito di telecamera dietro a quell’impressionante sipario liquido. Costui, oscillando come un pendolo, riesce ad affacciarsi all’ingresso della caverna e a filmarne l’interno. Herzog però non monta nel documentario quelle immagini uniche al mondo, lasciando il pubblico a bocca asciutta. Perché? La spiegazione ci viene da un ex capo indio del posto, che parla un inglese perfetto. Dice testualmente:
“ Nessuno sa cosa ci sia là dietro. Ci sono molte leggende. Alcune parlano di serpenti giganteschi che custodiscono tesori. Certo, sono solo leggende. Però non credo che dovreste divulgare quello che avete filmato. Ciò che vedi è tuo e devi tenerlo per te. Se perdessimo questo segreto l’intera essenza della nostra cultura rischierebbe di morire.”

La sequenza del documentario di Werner Herzog sembra favorire alla nostra riflessione immediati paralleli con il tema della opportunità delle descrizioni delle imprese in natura, sia speleologiche sia alpinistiche o di altro genere. ( filmate, fotografate o anche solo raccontate per iscritto) messe a disposizione di tutti i potenziali interessati. Argomento certamente stimolante e aperto a discussioni infinite. Da un lato Renzo Videsott che non lasciava traccia delle proprie prime ascensioni dolomitiche, dall’altra la precisione al dettaglio, tiro dopo tiro, gesto dopo gesto, delle attuali “topo guides” e degli schizzi che ai miei tempi si chiamavano “alla francese”. In mezzo porrei le guide di Ettore Castiglioni che spesso sintetizzavano in poche righe ascensioni di oltre 500 metri di dislivello.
Affrontare un’avventura, ipogea o montana – se non si è i primi a compierla – significa anche, psicologicamente, inserirsi in un’epica. Dare nuova vita, all’interno del proprio vissuto, a un evento storico che sconfina nel mito. E l’epica non può esistere senza una sua narrazione. Provo grande ammirazione per Videsott, ma, forse un poco a malincuore, mi colloco dall’altra parte. Dalla parte della storia narrata nel rispetto del mito che ne pilota l’articolazione e a quella narrazione dona un senso. Però lo faccio a una precisa condizione: che la narrazione non trascini dietro di sé – come la bava di una lumaca – iniziative volte a incrinarne o a sradicarne il significato autentico pur di metterlo a disposizione di un vasto pubblico superficialmente incuriosito . Per esempio grazie alla messa in opera di una via ferrata, o peggio, di un impianto di risalita meccanica.

Qui, oggi, non intendo addentrarmi più di tanto nel dibattito tra favorevoli e contrari alla narrazione, perché alla fine potrei andare fuori tema. Preferisco affidarmi ad un tipo di suggerimenti leggermente divergenti, sempre collegati alle immagini filmate da Herzog.
Voglio limitarmi a parlare brevemente della curiosità, prendendo l’avvio dal proverbio Zen che dice: “ Chi è solo curioso non ha diritti.”.
Anche in questa direzione trovo illuminante la sequenza del documentario di Herzog; perché suggerisce con semplicità e chiarezza quali siano i limiti etici della curiosità. Tanto l’alpinista europeo appeso alla corda, il quale realmente ha visto e ha filmato l’interno della caverna, quanto l’indio che vorrebbe avere le ali per entrarvi, coniugano la loro curiosità a una sfida ( autentica la prima, solo immaginata la seconda). Cioè si mettono in gioco. Sono disposti a rischiare per conoscere; sono disposti a rischiare, a faticare e a soffrire per gettare il loro sguardo “al di là”. Proprio come l’Ulisse di Dante Alighieri ( O frati dissi che per cento milia perigli siete giunti all’Occidente…). Se divulgassero ciò che hanno sperimentato (o sognano di sperimentare), mettendo a disposizione della massa dei curiosi – seduti in poltrona o sdraiati nelle amache – il cuore della loro avventura, ne snaturerebbero il senso. Il suo profumo si dissolverebbe nell’aria asfittica di una curiosità pigra e disimpegnata.
Mi sembra di poter dire che abbiamo a che fare con due tipi diversissimi di curiosità. La prima è la curiosità creativa ed attiva, radicata nel bisogno di conoscere e di varcare i confini del noto, anche a rischio della propria vita o del proprio equilibrio psichico: quell’impulso squisitamente umano che ha sempre guidato la nostra specie lungo il cammino della storia. La seconda è la curiosità passiva, epidermica e bulimica di chi pretende di poter abbeverarsi alla stessa sorgente senza sforzo; e per farlo non esita, se ce ne fosse il bisogno, a inquinare quella stessa sorgente; vale a dire a sterilizzare e fare a pezzi le condizioni di base che rendono praticabile per molti altri loro simili il primo tipo di curiosità. Come reagirebbe il nostro indio se a qualcuno saltasse in mente di costruire un ascensore scavato nella roccia per portare dentro la caverna i turisti di passaggio?

Per restare nel campo dell’alpinismo, già la costruzione ottocentesca del primo più che spartano rifugio ai Grands Mulets, causò notevoli dissensi e fu denunciato come una autentica profanazione della wilderness montana. Cosa che a noi oggi sembra inverosimile, abituati a ingoiare ben altri scempi.
“ Simili edifici” scrisse allora un alpinista inglese “grazie ai quali una curiosità banale può comodamente giungere ad ammirare scenari grandiosi, tradiscono il loro scopo. Sappiatelo! Se le comodità fanno due passi avanti verso il pittoresco, il pittoresco si ritira d’altrettanti passi!”
Basterebbe sostituire l’antiquato temine “pittoresco” con il più moderno “ paesaggio naturale” per ritrovate in questa breve frase una sorprendente modernità. Confesso che non mi dispiacerebbe poter stringere la mano a quell’inascoltato profeta. La sua sensibilità poteva e può apparire eccessiva; ma certo i suoi occhi interiori vedevano molto lontano.
Noi viviamo in una società in cui anche la curiosità più effimera e volatile ha assunto lo status di un diritto indiscutibile e come tale rende non solo lecito ma addirittura benemerito calpestare e umiliare qualsiasi altro valore. I flussi del turismo commerciale, basati su quel tipo di curiosità, non hanno avuto e non hanno la minima remora a stritolare, grazie alla forza del denaro, non solo paesaggi, ma anche antiche tradizioni, fedi religiose, investimenti affettivi profondi, trasformandoli in vuote crisalidi, buone solo per soddisfare l’indecente avidità delle macchine fotografiche del turista abbiente.
Prima di volgere lo sguardo sui problemi di casa nostra vorrei anche ricordare – perché fra poco ne comprenderete la pertinenza – il documentario “Kanehsatake della regista pellerossa canadese Alanis Obon-sawin, in cui si raccontano le ragioni di una rivolta armata, scatenata dagli indiani Mohawks nel 1993, contro la decisione degli abitanti bianchi della cittadina di Oka nel Quebec di invadere un’area cimiteriale sacra per ampliare un campo da golf.
Se restiamo in Italia constatiamo che, mutatis mutandis, le somiglianze tra ciò che succede qui e ciò che gli indiani tentano di difendere non sono poi così peregrine, se si scava al cuore della questione.

L’aggressione ludico/antropico/consumistica contro una diversa cultura minoritaria, alla quale noi tutti, alpinisti, escursionisti, speleologi, apparteniamo, avanza con la insensibilità di uno schiaccia-sassi, sostenuta da interessi mercantilistici che fanno allegramente “carne di porco” di qualsiasi altra prospettiva. Siano tali prospettive ecologiche, poetiche o esistenziali.
In montagna, per permettere alla curiosità superficiale di una falange di turisti di gettare uno sguardo sui panorami dell’alta quota, utilizzati come fondale di innumerevoli “selfie”, si continua a delegittimare il vero senso dell’ esperienza alpinistica, cloroformizzandone il potenziale messaggio contro-culturale, anche tra chi l’alpinismo lo pratica. Noi lo sappiamo per esperienza diretta: quel messaggio ci parla certo di avventura, di libertà creativa, di responsabilità di fronte ai pericoli, di conoscenza dei propri limiti estremi, di silenzio e solitudine, di rispetto per l’ambiente naturale.
Ma non solo. Suggerisce anche che c’è una profonda differenza qualitativa tra l’atto di guardare e quello di vedere; di conseguenza i due termini sono tutt’altro che sinonimi. Anzi, spesso il primo tende a soffocare il secondo.
Eccoci al punto chiave: la curiosità di chi “guarda e non vede” dovrebbe arrestarsi – per elementare decenza – ai confini di quei territori geografici e dello spirito dove regnano le ragioni di chi invece si mette totalmente in gioco, affrontando fatiche e pericoli, per “vedere” cosa brilla, fuori e dentro di sé, al di là delle apparenze immediate e degli scenari pittoreschi.
Mi si obietterà: per quale ragione la maggioranza, formata dai semplici curiosi, dovrebbe cedere il passo alle pretese puriste di una minoranza?
Ebbene si, non ho paura di affermarlo: è proprio questo che dovrebbe accadere in un paese civile. La società in cui viviamo, se fosse in grado di distinguere il peso etico dei valori in gioco, dovrebbe riconoscere il dislivello incolmabile tra i due termini a confronto. E agire di conseguenza per rispettare i bisogni immateriali delle minoranze, difendendoli dall’omologazione consumistica.
Già in passato ho fatto lo stesso esempio: posso anche essere ateo, ma lotterei con tutte le mie forze per vietare che una chiesa, pur se frequentata da un pugno irrilevante di fedeli, venga trasformata in una discoteca, per ospitare nel suo interno una folla molto più numerosa. Sarebbe un delitto porre sullo stesso piano qualitativo esperienze così diverse per significato, profondità, coinvolgimento affettivo. Ma allora, si continuerà a obiettare, la maggioranza dovrebbe tirarsi da parte di fronte alle pretese campate in aria di qualsiasi gruppo di invasati?
Mi rifiuto di abboccare all’amo di tali generalizzazioni ingannevoli.
Il bisogno di un’ immersione attiva nella natura incontaminata che una parte non indifferente dei nostri simili sente con forza e attraverso la quale trae tanta forza, ha le carte in regola per essere accolta e favorita come un reale, positivo antidoto contro un sistema socio-economico che tende a programmare ogni nostro comportamento e a condizionare in mille modi sottili la nostra capacità di giudizio.

Se questo è vero per chi cerca se stesso salendo verso levette, mi sembra sia ancora più vero per chi scende nelle viscere della terra.Per due ragioni. La prima è che il gradiente di curiosità degli speleologi mi sembra sia maggiore e più determinante di quello degli alpinisti. Le squadre degli speleologi organizzano le loro spedizioni perché mossi essenzialmente dalla curiosità di scoprire cosa ci sia sul fondo. Dunque, se così stanno le cose, mi sembra urgente e irrinunciabile l’esplicita e piena assunzione culturale e la difesa intransigente di quel tipo di nobile curiosità. La seconda ragione è che l’aggressione agli ambienti ipogei è stata almeno altrettanto grave e becera delle trasformazioni subite dalle montagne per trasformarle in luna park. La manomissione delle grotte di Postumia, con tanto di trenino e illuminazione elettrica, segue di pochissimi anni la costruzione della capanna Margherita sulla vetta della punta Gnifetti, spianata con la dinamite alla fine dell’800. Gli esempi negativi si sprecano: basta pensare a Castellana, al Gigante, a Frasassi, a Stiffe.
So bene – e non venite a dirmelo quasi si trattasse di una giustificazione – che lo sfruttamento in stile Luna park delle grotte turistiche coinvolge solo in Italia un milione di visitatori ogni anno.Il giro di affari che ne deriva è imponente. Imponente e evidente. Ma altrettanto evidente è la profanazione radicale di quegli ambienti. Sono ambienti straordinari, figli però delle tenebre e del silenzio, da esplorare in punta di piedi con rispettosa meraviglia; mentre ora sono gettati in pasto alla superficiale curiosità di una torma di visitatori con l’ausilio di volgari effetti luminosi, passerelle,mancorrenti, musiche di sottofondo e chi più ne ha più ne metta. Le cavità ipogee trasformate in spettacoli di suoni e luci mi fanno pensare agli orsi ammaestrati che ballano nelle fiere paesane in Turchia. Anche lasciando da parte i crudeli stratagemmi utilizzati per il loro addestramento, mi rattrista l’umiliazione del significato simbolico legato a quei plantigradi selvatici. L’animale che nelle tradizioni di tante culture racchiudeva in sé l’essenza della natura indomabile e ne era il signore, viene degradato a giocattolo, esposto senza difesa alla curiosità impudica della plebe che ne fa oggetto di lazzi volgari.

Conosco poco il mondo ipogeo e le aspirazioni di chi lo frequenta con coraggio. Dunque mi scuso in anticipo se mi azzardo ad esporre alcune riflessioni probabilmente in più punti imprecise. Ho la sensazione che gli speleologi dovrebbero ribellarsi con maggiore determinazione contro lo sfruttamento turistico delle cavità ipogee, al fine di ottenere per legge il divieto di ulteriori manomissioni e il contenimento di quelle già in atto. Però intuisco l’esistenza di un altro pericolo:un virus comportamentale che potrebbe celarsi non fuori ma dentro la stessa spinta all’esplorazione speleologica. La curiosità di andare a vedere cosa c’è sul fondo, al termine del percorso ( ammantata di giustificazioni scientifiche spesso labili e pretestuose), può diventare così impellente da portare alla tentazione di superare gli ostacoli “ a qualunque costo”. A qualunque costo:anche usando picconi e mine. Questo è male. Ed è un male grave. Grave, perché presuppone una mancanza di rispetto verso l’ambiente naturale e perché fa arretrare arbitrariamente, in una forma particolarmente aggressiva, i confini dell’impossibile. Recentemente il mondo dell’alpinismo è stato sconvolto dal sospetto che il crollo del famoso “Hillary Step” lungo la cresta finale dell’Everest, non sia stato causato da un terremoto, ma sia dovuto all’opera di un manipolo di Sherpa pagati dalle spedizioni commerciali per rendere più snella la salita e la discesa dalla vetta a favore delle interminabili carovane dei loro clienti. Un paio di mine e l’intoppo è stato eliminato.Se ciò rispondesse al vero sarebbe un autentico sacrilegio. Ma il giudizio non può cambiare se l’esplosione avviene al buio, nelle viscere della terra.
Rispettare l’ambiente naturale equivale a rispettare se stessi e i propri sogni.
Carlo Alberto Pinelli
