Alpinismo: no patacca!
L’alpinismo, nella sua totalità, è stato messo in lista perché l’UNESCO lo riconosca patrimonio culturale immateriale. Di seguito pubblichiamo alcune riflessioni in merito di Carlo Alberto Pinelli.
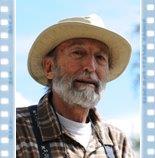
Nell’ottobre del 2003 l’UNESCO ha deciso di inserire nel proprio elenco dei Monumenti del Mondo (World Heritage) anche la categoria dei patrimoni culturali immateriali. L’elenco, che in pochi anni ha raggiunto centinaia di voci, comprende prevalentemente usanze e saperi di carattere demo-etno-antropologico, legati a culture tradizionali, più o meno in via di estinzione. Dentro si trova un poco di tutto: carnevali esotici, teatri delle ombre, cantastorie dell’Asia Centrale, musiche dei Pigmei, condimenti polinesiani, danze baltiche, scuole di samba brasiliane, ecc.
Per quel che riguarda l’Italia, sono entrati in quel pantheon evanescente: il canto “a tenore” dei pastori sardi, l’opera dei pupi siciliana, la dieta mediterranea, pizza compresa (!). Mi sembra che la trovata escogitata dall’UNESCO sia piuttosto patetica e funerea: un volonteroso ma velleitario tentativo di conservare, imbalsamandoli, frammenti isolati di espressioni culturali, spesso subalterne, ormai condannati a scomparire. L’Alpinismo ha bisogno di tali compagni di strada?

Perché questa domanda? Perché già nel 2011 i sindaci dei comuni di Courmayeur e Chamonix avanzarono la proposta di candidare a far parte di quell’elenco niente meno che l’alpinismo. Anzi, per essere specifici l’alpinismo classico, identificato con la storia della conquista del Monte Bianco. Il sindaco di Courmayeur disse allora che per patrimonio immateriale si deve intendere l’etica dell’alpinismo, ma anche le sensazioni uniche che una scalata può offrire. A queste banalità si aggiunsero le riflessioni del sociologo Enrico Finzi, secondo il quale – cito quasi alla lettera – l’alpinismo dovrebbe essere riconosciuto dall’UNESCO in quanto portatore di valori come il rispetto per l’ambiente, la cooperazione, la solidarietà e l’ecologia esistenziale, da associare alla sobrietà e alla ricerca dell’equilibrio nella consapevolezza dei propri limiti. Allora non se ne fece niente.
Oggi questa balzana proposta sembra stia riprendendo fiato e ciò stimola un’approfondita riflessione di cui le presenti pagine possono rappresentare soltanto una traccia preliminare. Non sarò certo io a negare che l’alpinismo, cioè l’incontro dell’uomo moderno con la sfida dei grandi spazi verticali e incontaminati, possa propiziare l’emergere e il rafforzarsi di alcuni dei valori di cui scriveva Finzi, qualora l’alpinista abbia già maturato in sé, nella vita di tutti i giorni, una sincera “permeabilità” al loro recepimento. Ma, posta nei termini perentori e istituzionali con cui è stata enunciata, tutta la faccenda puzza di retorica lontano un miglio. E anche, purtroppo, di retorica a buon mercato. E’ fin troppo facile ricordare quanto già disse Voltaire a Jean-Jacques Rousseau: “Sarebbe bello se per diventare migliori bastasse salire a quote più alte!”.

La verità è che l’alpinismo, in quanto categoria “metastorica” non esiste. Tanto meno deve essere visto come una sorta di “chiesa” con i suoi dogmi e i suoi comandamenti. Noi anziani possiamo aver vissuto direttamente gli ultimi palpiti dell “alpinismo eroico”, legato a nobili modelli ideali (spesso traditi nella pratica!) e di conseguenza possiamo a ragione riconoscerci emotivamente e eticamente in quel modello. Ma ciò non giustifica la pretesa di sottrarre l’alpinismo attivo a evoluzioni storiche che possono non piacerci, per incastonarlo in una teca autoritaria e mummificata. Quelli che esistono sono solo gli alpinisti, tutti figli delle culture delle proprie epoche e delle proprie storie individuali, con i pregi, le debolezze e i difetti che da ciò derivano. Nel novero rientrano gli alpinisti che per decenni hanno abbandonato i propri rifiuti ai piedi e sulle pendici delle grandi montagne asiatiche (“rispetto per l’ambiente?”), hanno evitato di soccorrere altri scalatori in difficoltà perché se lo avessero fatto sarebbero stati costretti a non raggiungere la vetta (“solidarietà e cooperazione”?), non hanno mosso un dito per contrastare l’assalto consumistico e speculativo alle montagne europee e asiatiche, hanno organizzato e diretto deleterie spedizioni commerciali, ecc. D’altro canto nello stesso novero si collocano gli alpinisti che invece si sono comportati e si comportano in modo diametralmente opposto, ponendo al vertice delle proprie esperienze il perseguimento di tali valori. A nobilitarli basta la loro coscienza e non c’è bisogno di un sigillo “patacca” dell’UNESCO.

Insomma credo che sia necessario e inderogabile respingere la retorica da quattro soldi che, idealizzando la “lotta con l’Alpe” al di là del ragionevole, tende a coprire e a nascondere troppe scomode verità. La pratica dell’alpinismo, al pari di tante altre discipline (ad esempio la meditazione yoga o quella zen), può portare alla liberazione, ma può anche rendere più solide le sbarre della cella in cui è imprigionato il nostro io. Ovvero rappresentare l’alibi, ingannevolmente eroico e autogratificante, per una fuga verso il nulla. L’insensata corsa del criceto nella ruota della gabbia.
Se proprio vogliamo trovare un lato positivo alla proposta, questo sta nella possibilità di dichiarare esplicitamente non-alpinismo le ascensioni all’Everest e agli altri Ottomila compiute dalle spedizioni commerciali con esteso uso di corde fisse, bombole di ossigeno e servizievoli squadre di portatori/guide sherpa. Ma chiediamocelo chiaramente: per condannare tali pratiche ci serve proprio il timbro di garanzia dell’UNESCO?
L’alpinismo resta, nonostante tutto, un’isola di libertà. E la libertà ha i suoi rischi. E’ illusorio credere di poterli tenere sotto controllo agendo “dall’esterno”.
Carlo Alberto Pinelli
